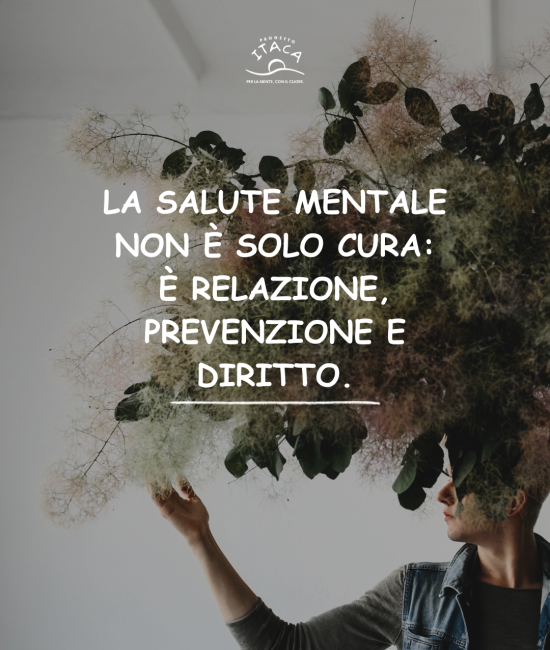
C’è un agile e interessante libretto uscito per le edizioni Il Margine dal titolo La salute mentale è un diritto, scritto dal grande psichiatra e psicoterapeuta Luigi Cancrini. È un libro che aiuta con semplicità a fare luce su alcune questioni che questo momento storico di tagli alla sanità e aumento crescente del bisogno di cure pone alla psichiatria nel nostro Paese. Cancrini parte dalla constatazione che la rivoluzione nella salute mentale avviata da Basaglia ha rivoluzionato le istituzioni ma non ha cambiato l’assunto di fondo: si continua a guardare alla salute mentale come una questione esclusivamente medica. Invece, ci ricorda l’autore, i “disturbi psichiatrici hanno molto di più a che fare con le relazioni delle persone, che non con il funzionamento del cervello”.
Questo presupposto, semplice ma discriminante, genera due inevitabili conseguenze: se “il modo in cui il cervello funziona è alterato in conseguenza delle sofferenze che provengono dal vissuto della persona” la psicoterapia, rispetto al farmaco, avrà un ruolo determinante nell’affrontare la sofferenza psichica; inoltre, e questo è un tema a mio avviso sempre troppo trascurato, si può e si deve, socialmente, agire sulla prevenzione durante i primissimi anni di infanzia. “L’infanzia dei bambini è il tempo in cui, se le cose vanno male, si determinano le linee di frattura che si evidenzieranno nelle difficoltà della vita.” Ci rompiamo là dove ci siamo crepati quando eravamo piccoli e non avevamo possibilità di proteggerci. Per questo è necessaria per Cancrini una maggiore attenzione ai più piccoli ma anche alle giovani madri, che necessiterebbero di supporto psicologico fin dalla gravidanza e nei primi anni del bambino. Una spesa importante? Certo, ma sostenibile secondo l’autore, a fronte di un risparmio sul disagio in età adulta negli anni a venire.
Anche sull’approccio psicoterapico il nostro paese è estremamente carente: manca una formazione in tal senso tra i professionisti della salute mentale. Non è prevista per gli psichiatri, nei servizi ci sono pochissimi psicoterapeuti di ruolo, e la psicoterapia rimane appannaggio di pochissimi o di chi la può pagare privatamente. Anche su questo, l’autore sembra aprire un varco, concentrandosi più che sull’offerta all’utente sulla formazione del personale, che virando maggiormente verso un approccio psicoterapico sarebbe in grado di accogliere il vissuto del paziente in una dimensione di attivazione di risorse. “Non basta – quindi – che qualche psicoterapeuta prenda in carico situazioni circoscritte, serve riuscire a infondere elementi di riflessione psicoterapeutica nella gestione dei casi”: è questo il centro della riflessione dello psichiatra, che introduce così un approccio metodologico preciso, in cui la psicoterapia è un metodo di lavoro e uno strumento di prevenzione, laddove riesce a intercettare, soprattutto nell’infanzia ma non solo, segni di disagio prima che si manifestino in un disturbo vero e proprio.
In questo senso mi sembra che questa riflessione porti avanti il lavoro iniziato da Basaglia che a un certo punto si è interrotto; se è vero che il contributo del grande psichiatra triestino è stato, anche, quello di insegnarci a guardare le persone malate come persone, prima che come malattie, ora quello che sembra emergere da questa lettura è che serva un passo in più. Persone, certo, e in quanto tali collocate in un universo di relazioni che le definiscono, che possono ferirle, ma che nelle relazioni terapeutiche possono trovare anche un risanamento.
Articolo di Camilla Endrici,
dal progetto di Attivismo Digitale.
