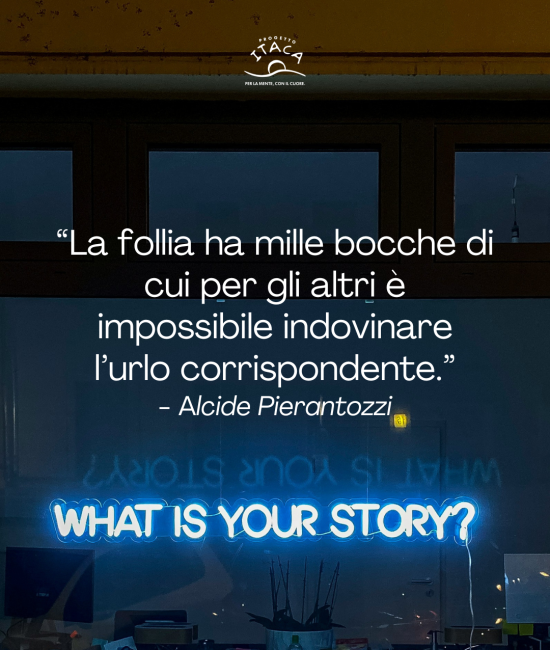
Siamo già sul finire di Lo sbilico quando l’autore, Alcide Pierantozzi, dichiara apertamente quello che traspare, riga per riga, nello straordinario racconto autobiografico della sua malattia mentale. Da anni leggo saggi e romanzi su questo tema, ma raramente mi è capitato di incontrare una simile lucidità. Non solo: la grande consapevolezza dell’autore si accompagna a una ricerca sul linguaggio raffinatissima e originale, che inserisce questo libro, non a caso edito da una grande e stimata casa editrice come Einaudi, a pieno titolo nell’ambito della letteratura. In questo senso questo romanzo si distanzia totalmente dal compiacimento di certa narrazione di malattia, che si presenta più come un flusso di coscienza (ben poco cosciente, a confronto di questo), uno sgorgare spontaneo laddove l’autenticità viene confusa come un’assenza di mediazione mentale, di ragionamento attento sulle parole da usare.
Pierantozzi fa esattamente il contrario: sceglie le parole come strumenti preziosi per una chirurgica operazione di analisi di sé stesso, e nel farlo attende, cerca, pondera, misura. “Le parole difficili cristallizzavano l’insetto e me lo mostravano ingrandito. Allora forse il mondo è affamato di parole, mi dissi. (…) Così il bambino puzzolente di pomodoro, stretto al suo microvocabolario, cominciò a mettere in fila la squadra delle sue paure per arbitrarla con le parole”. Si sente, si percepisce che ogni riga nasce da un tempo di gestazione meditato. Ed è forse in questo tempo di attesa che nasce, anche, la piccola tregua con il proprio delirare che le parole permettono: “L’indescrivibilità non esiste, bisogna solo attendere le parole giuste, come i corvi”.
“Le parole più belle, più strane, riescono a inibire le allucinazioni”, scrive l’autore, al quale si deve rendere il merito di una comprensione disarmante del suo funzionamento: “So anche come si comportano, le allucinazioni. È difficile spiegare che tipo di rapporto si stabilisce tra me e loro, perché è difficile mettere in discussione qualcosa che si vede con gli occhi. Ma credo di aver sviluppato l’intelligenza per farlo. Prima il linguaggio, poi l’intelligenza.”
Questa priorità assoluta data al linguaggio nel rapportarsi all’esistenza e alla propria condizione, è un’arma a doppio taglio: se da un lato il linguaggio permette di domare la realtà, dall’altra è vero che è proprio nel linguaggio che a volte il mondo si frantuma: una fissazione sul suono di una parola, su una lettera, fa scaturire un’allucinazione: “La parole, le loro sillabe, le loro lettere pallottolose, il loro inchiostro schiacciato sulla pagina, il loro suono, funziona da diserbante o da concime”. La grande capacità di Pierantozzi è però allora quella di avere una lucidità che permette di vedere e raccontare i percorsi del proprio delirio. E qui, credo, sta uno dei grandi pregi di questo racconto: fungere da “mediatore”, da “traduttore” tra il linguaggio della normalità e quello della follia. Uso non a caso la parola normalità, che lo stesso Pierantozzi definisce in modo lapidario: “un individuo normale, per me, è qualcuno non sottoposto a terapia farmacologica o psicoterapeutica, funzionale e autosufficiente in tutto”. Forse una visione un po’ estrema di normalità, cui pochi potrebbero aderire, ma certo nata dal proprio vissuto di eterno estraneo alla vita.
Pierantozzi ci porta con mano nel suo mondo allucinato e disaggregato di psicosi: “La follia ha mille bocche di cui per gli altri è impossibile indovinare l’urlo corrispondente (….) Dopo una crisi, anche se breve, il cervello per riassestarsi non può ricalibrarsi da solo: se vuole sopravvivere, ha la sola possibilità di cambiarlo, il mondo.” Quanta consapevolezza in questa descrizione. C’è da dire che Pierantozzi, oltre a una diagnosi di disturbo bipolare, ha una neurodivergenza (è diagnosticato come Asperger): nella commistione di questi due aspetti, probabilmente nasce il dolore profondissimo in cui si trova a vivere ma anche un pensiero completamente differente dall’ordinario. Il fatto è che Pierantozzi a differenza di molti altri lo sa, e sa come dirlo: “Non sanno che quasi sempre è per una sovrabbondanza di logica che vado in tilt”, scrive. E non c’è pagina, in questo libro, in cui non si abbia la sensazione che il funzionamento dell’autore sia molto spesso un iper-funzionamento, che lo porta in territori in cui la normalità, in questo più ordinaria, non arriva.
Certamente la condizione dell’autore è eccezionale, se lo stesso psichiatra gli dice che “gli altri pazienti, a differenza sua, non ragionano in modo così maniacale sulla propria condizione di malati”; eppure è proprio questa eccezionalità a cui dobbiamo essere profondamente grati, perché ci permette di attraversare i territori desolati della malattia mentale con una straordinaria mappa. Nessun compiacimento nelle parole di Pierantozzi, mai un indugiare sulle conseguenze della propria condizione, ma un ritratto nitido senza sconti di una vita interamente dedicata a gestire la convivenza con una malattia molto invalidante.
“Anche io sono uno stabilimento balneare che sulla spiaggia della realtà ci sta abusivo, nella sessualità ci sta da abusivo, nell’identità del corpo ci sta da abusivo”, scrive Pierantozzi. Il suo racconto non è (come è di moda adesso) il racconto di una redenzione, di una rinascita, di una “vittoria” edificante sulla malattia. Non è un viaggio dell’eroe, non ci sono premi né gloria in fondo. Il suo racconto è un’istantanea dolorosissima e al contempo molto vera sulla malattia mentale. “Io un progetto di salvezza non ce l’ho. Io vivo un passetto alla volta, una riga alla volta, resisto un’ora alla volta, vado da A a B. I giorni non mi garantiscono più niente e io stesso non mi autogarantisco che piccolissimi obiettivi per andare avanti. La scrittura a mano riesce ad arginare i pensieri per il tempo di una frase. Lascio al futuro la libertà di fare progetti su di me”. Per parte mia, spero che il futuro ci conceda ancora molti libri di questo autore.
Articolo di Camilla Endrici,
dal progetto di Attivismo Digitale.
