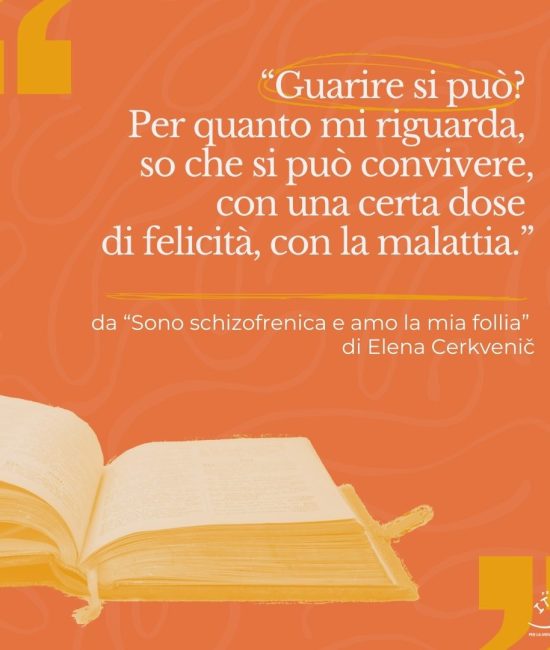
Da un po’ di tempo mi trovo a riflettere sulla narrazione della malattia mentale e della malattia in generale. Penso, ad esempio, all’abbondanza di racconti su quella che viene chiamata la “battaglia contro il cancro”, ma anche a certi influencer che fanno della loro disabilità fisica un cavallo di battaglia per affrontare missioni impossibili. Per carità, è tutto molto bello, edificante, resiliente (per usare un’altra parola di moda), a tratti glamour. Ma mi chiedo: per ogni persona che ce la fa, per chi riesce a vivere in modo straordinario la propria malattia, quanti “normali” ci sono? Quante persone non trasformano la malattia in un insegnamento spirituale, quanti non diventano super atleti o famosi non nonostante la malattia, ma proprio grazie alla malattia? Immagino molti.
Tra i tanti che conosco e che definirei, con affetto, “sfigati” (includendo me stessa), nessuno è speciale. Eppure, lo sono tutti, perché vivono, nonostante tutto.
Mi sono chiesta anche come sarebbe possibile raccontare una “normalità difettosa”, perché una storia, come ci ricorda Vogler, richiede che l’eroe compia un viaggio, affronti ostacoli, cada e si rialzi in un punto più elevato. Il libro Sono schizofrenica e amo la mia follia fa esattamente questo: ci racconta l’armistizio con la malattia mentale, non la battaglia né la resa, ma il tentativo di convivenza. Non ci sono mostri da sconfiggere o battaglie da vincere, ma ombre con cui convivere. Ombre anche molto scure. Ma la convivenza è lì, nella vita che abbiamo, nell’appartamento che abitavamo PRIMA, non altrove.
Da questo incontro con l’ordinarietà della malattia nasce questo diario autobiografico, il primo di una nuova collana, 180 – Archivio critico della salute mentale, curata da Peppe Dell’Acqua per Meltemi. L’autrice è la triestina Elena Cerkvenič, che da molti anni convive con la malattia mentale. “Guarire si può? Per quanto mi riguarda, so che si può convivere, con una certa dose di felicità, con la malattia”, scrive Cerkvenič, che in questo breve romanzo autobiografico racconta una vita fatta di piccole cose, piccole gioie che, riconosciute, le permettono di accogliere la malattia mentale nella sua vita. La meticolosità con cui vengono descritte certe azioni – memorabile per me il lavaggio dell’insalata – ricorda quasi una meditazione zen, simile a quella del protagonista di Perfect Days di Wenders.
La cura per le piccole cose della vita alimenta una stabilità che a volte si incrina, ma l’autrice non indugia su questi momenti, preferendo dare spazio al suo quotidiano esercizio di gratitudine: “Perché i dettagli, e l’aver imparato ad apprezzarli, compongono i miei momenti di inaspettata felicità. Una filosofia delle piccole cose, di gesti calibrati e consapevoli, che dà corpo e allarga e fa profondo lo spazio e il tempo del mio tempo, quando mi libero dal male”. E anche se il titolo, così dirompente, potrebbe far pensare a un racconto dettagliato della violenza della malattia mentale, non è così. Questo è un racconto in punta di piedi, molto più difficile da un punto di vista della suggestione narrativa, ma assai più interessante per comprendere davvero la normalità di chi convive con un disagio mentale. “Ma che cos’è poi la follia? È un’identità, credo, ma deve essere curata”. In questa semplice frase si cela la disarmante verità della sofferenza mentale: una dimensione identitaria, prima che patologica, ma che richiede, per essere vissuta, di essere curata.
L’autrice è paziente del Centro di Salute Mentale di Trieste, è un’ESP (Esperta di Supporto tra Pari) e vive in modo attivo il Servizio, frequentando diversi gruppi e dimostrando con la sua esperienza come il modello triestino sia ancora oggi un esempio da seguire.
Articolo di Camilla,
per il progetto di attivismo digitale.
